
|
|
Sito Principale CANICATTI' |

IL BARONE AGOSTINO LA LOMIA, ULTIMO DEGLI ARCADI E DEI GATTOPARDI
Era ben lontano allora il barone dal pensare che la Parca gli avrebbe reciso lo stame appena due lustri dopo, il 21 gennaio 1978. Era uscito da poco dal suo settecentesco palazzo, dopo una rigida volontaria clausura, durata sette lunghi interminabili anni, in cui sogni da incubo gli avevano reso angosciosa l'esistenza. Tornava finalmente a vivere, ma a vivere con filosofia, convinto che, come soleva ripetere, "tutto nella vita è sciocchezza più o meno importante". E può sembrare strano che proprio chi tornava a vivere pensasse innanzi tutto alla morte. Ma egli stesso ebbe a dichiarare a un giornalista che la vera nascita è la morte. Aveva ragione, quindi, di pensare alla vita, brindando alla morte. E non una, ma due tombe voleva assicurarsi per l'eternità: la prima alla Chiesa Madre, la seconda al cimitero, come a garantirsi una residenza di città per svernare e una di campagna per villeggiare. Poté disporre, però, solo dell'avello cimiteriale, poiché il sarcofago ecclesiale, ereditato dagli avi, gli venne ostruito di terra: egli se ne dolse molto, ma si consolò ben presto, predisponendo le proprie onoranze funebri. Come Pirandello, anche lui espresse il desiderio di essere posto nudo nella bara; e su di essa ordinò si adagiassero quaranta sacchetti di terra, reliquie di suoi altrettanti feudi. E volle che delle esequie si curassero sedici becchini internazionali, accompagnati da un notaio dalla mano adunca, da un ingegnere con un piccone e da un politico con una forchetta. Dietro la berlina funebre, trainata da candidi cavalli, dovevano sfilare in corteo quattrocento invitati ufficiali, la banda di Acireale e un'infinità di inservienti con vassoi colmi di gelati da distribuire a tutti i partecipanti. Più che un funerale sarebbe stata una festa. 
Ben diversa, però, si è rivelata la realtà. E' stata una mesta cerimonia quella che una fredda domenica d'inverno ha accompagnato all'estrema dimora l'ultimo dei gattopardi, il barone di Renda e Carbuscia Agostino Fausto La Lomia. Poche corone e non più di cinquanta persone ne seguivano il feretro, adagiato su uno sgangherato carro, che un sonnolento autista, alle tre pomeridiane, faceva incedere lentamente, col passo della morte. Certamente più solenni erano stati i funerali del suo gatto, "S.E. il Referendario Paolo Annarino", di cui, con tanta affettuosa premura, si era interessato lo stesso "don Turiddu Capra, duca di Santa Flavia e Merlo, nominato dalla patrizia magnanimità anche "monsignore". Gatto e merlo erano compagni inseparabili del barone. Da quando era morto padre Meli, parroco di San Domenico, il gatto, rimasto senza padrone, si era affidato ciecamente al barone, il quale lo aveva fatto assurgere alla nobiltà del merlo, creandolo "Referendario" del regno di Capo La Croce, isola del mar taorminese. Non c'era festa o festival, a Taormina, a Venezia, a Roma o a Montecarlo, in cui barone, gatto e merlo non comparissero insieme: dentro una gabbia di vimini il referendario e, in una di ferro, l'acquatico duca di Santa Flavia; e lui, il barone, nel mezzo, con folta e fluente barba, in abito estroso, con ampia cravatta a fiocco e immancabile fiore bianco all'occhiello. 
Purtroppo il gatto "annarino" perì non molto dopo, travolto dalla frenesia automobilistica della vita moderna. Ne diede notizia il "Giornale di Sicilia" con un patetico necrologio: "Investito da mano pirata è deceduto tragicamente il 5 agosto 1969 a Canicattì S.E. il Referendario Paolo Annarino e Gatto. Ne dà il triste annunzio don Turiddu Capra, duca di Santa Flavia e Merlo, che lo ebbe padre, fratello e amico. I resti mortali saranno tumulati di fronte al mare Ionio nell'isola di Capo La Croce in quel di Taormina". Della perdita del "padre, fratello e amico", però, si consolò presto il merlo, tra condoglianze e libagioni di latte. Lo attendeva, tutta per lui, una camera con bagno del lussuoso Hotel San Domenico di Taormina. Meritava il massimo rispetto questo merlo, che non si staccava mai dal suo mecenate e ne accompagnava col fischio le note di "Vitti 'na crozza", suonate alla chitarra. E, quando il barone riceveva le belle donne, le stelle e le stelline del cinema, il blasonato uccello occupava sempre il posto d'onore. Anche lui, come il suo signore, era sensibilissimo al fascino muliebre. Mondanità e beltà lo suggestionavano. Non voleva, però, sentir parlare di religiosità: era costretto, perciò, il barone a recarsi senza di lui in chiesa o a ritirarsi solo in meditazione, quando dai sogni di gloria mondana passava alle pratiche di esaltazione religiosa, memore del legame che lo univa al suo grande parente, Padre Gioacchino. Lo induceva alla religiosità anche il titolo di abate laico, ereditato dall'avo barone Marco La Lomia, che nel Settecento lo aveva ricevuto dalle mani del cardinale e del re, in riconoscimento dell'impegno di far celebrare la messa nella tenuta di Giacchetto, già delle suore benedettine del monastero "SS. Salvatore" di Naro. Padre Meli era il suo don Pirrone: non c'era sera che non fossero insieme a pregare, a conversare e a cenare. Dovevano esserci dotte dispute tra loro, poiché il barone era fervente cultore di tradizioni popolari, e tanto contribuì con i suoi scritti, le sue pubblicazioni e i suoi articoli alla conoscenza del folklore canicattinese e siciliano. 
Non è senza significato la sua appartenenza all'Accademia del Parnaso, tra gli arcadi minori, insieme con una eletta schiera di uomini colti e di spirito. Certo, era un' accademia un po' bizzarra questa del Parnaso, che aveva per emblema un'asina alata e in cui, per statuto, gli arcadi minori erano "i non maggiori", e viceversa. Tuttavia riuscì a unire in sodalizio uomini illustri, che della satira politica e sociale fecero la loro arma nella lotta contro l'insipienza e il malcostume. E fu tanto l'interesse da essa destato, che personaggi come Luigi Pirandello, Marco Praga, Giovanni Gentile, Marinetti, Trilussa, Marta Abba, Angelo Musco e altri diedero la loro entusiastica adesione. Si disse allora che essa poteva garantire l'immortalità: di sicuro la raggiunse il presidente don Ciccio Giordano, "oste e poeta sovrano", perché ai suoi funerali, chiamato l'appello secondo l'uso fascista, si levò corale da tutti gli astanti il grido: "Presente". Sicché l'avv. Sanmartino commentò subito con il dottore Stella che gli stava accanto: "Se il presidente, da morto, risponde "presente" è segno che non è morto: dunque è immortale". E fu così che i parnasiani gli riconfermarono per l'eternità dei secoli la presidenza della Serenissima Accademia, mirabilmente conciliante cani e gatti, uomini e somari. Suo vicario in terra rimase il barone Agostino Fausto La Lomia, il quale gli arcadi più insigni onorò con la commenda dell'Ordine accademico di Capo La Croce, ionica propaggine del Parnaso. Avrebbe voluto anche convocarli tutti nella sua isola sovrana, ma non lo consentì la tirannia della sorte. Si spensero gli arcadi l'un dopo l'altro: e, ultimo, si estinse anche lui, in solitudine. Diego Lodato, Agostino Fausto La Lomia, barone di Renda e Carbuscia, ultimo degli arcadi e dei gattopardi, in La Torre, a. XXVIII n. 18, 4 ottobre 1981 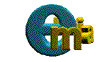 solfano@virgilio.it solfano@virgilio.it
|
 Il 22 ottobre 1967, nel grigio pomeriggio di una domenica autunnale, veniva inaugurata nel cimitero di Canicattì, con un gran brindisi di vino rosso e pasto di mandorle, una fastosa tomba gentilizia. Il "morto", però, era ancora vivo: il barone di Renda e Carbuscia, cui l'aristocratico sepolcro apparteneva, stava con volto ridente e pago, dinanzi al proprio epitaffio: "Qui giace Agostino La Lomia, nato il 30 gennaio 1905 e morto il ...".
Il 22 ottobre 1967, nel grigio pomeriggio di una domenica autunnale, veniva inaugurata nel cimitero di Canicattì, con un gran brindisi di vino rosso e pasto di mandorle, una fastosa tomba gentilizia. Il "morto", però, era ancora vivo: il barone di Renda e Carbuscia, cui l'aristocratico sepolcro apparteneva, stava con volto ridente e pago, dinanzi al proprio epitaffio: "Qui giace Agostino La Lomia, nato il 30 gennaio 1905 e morto il ...".